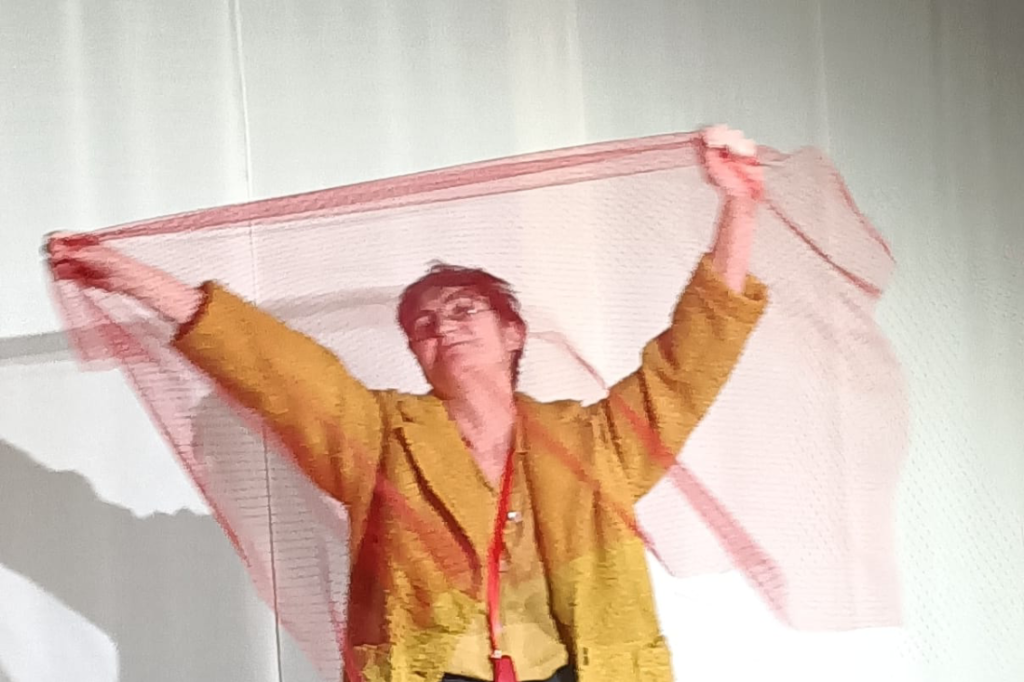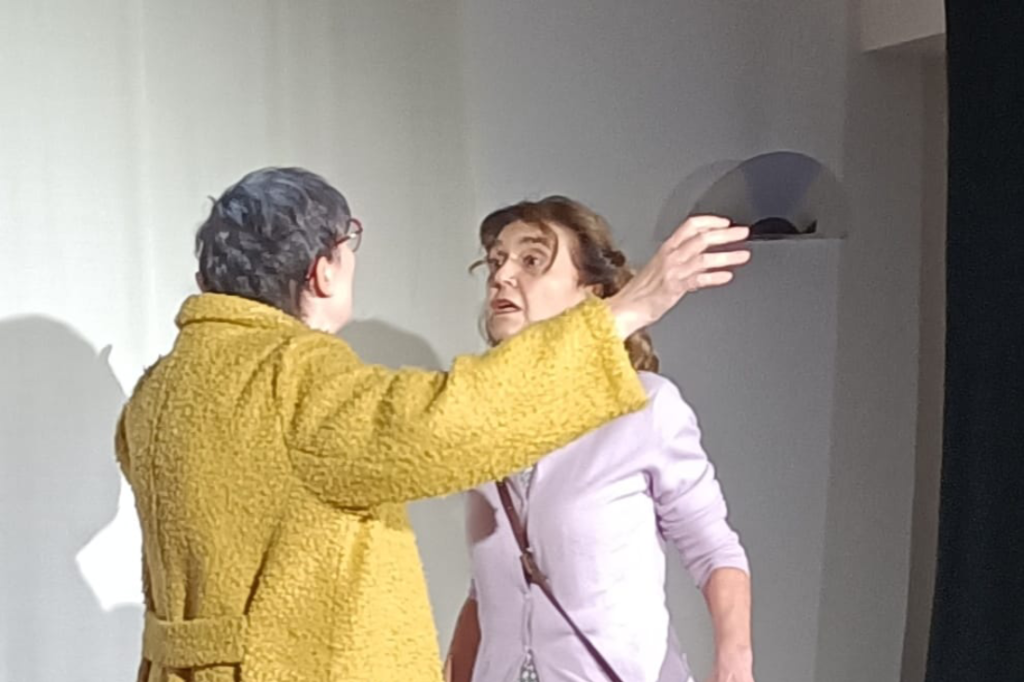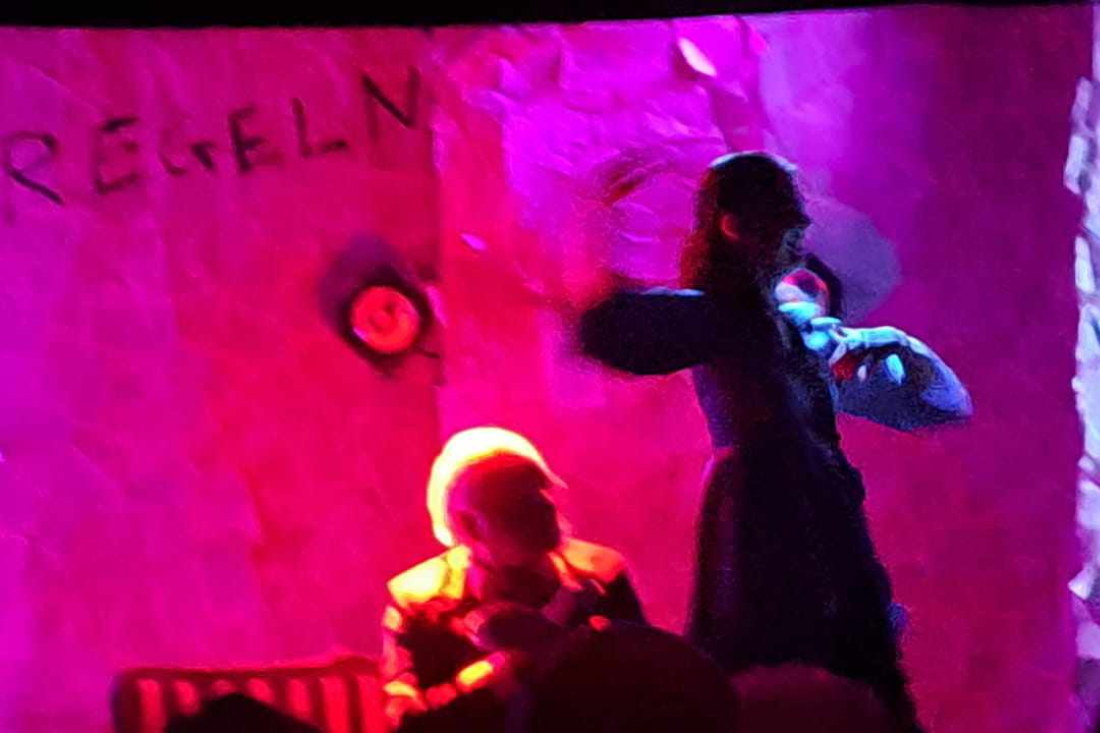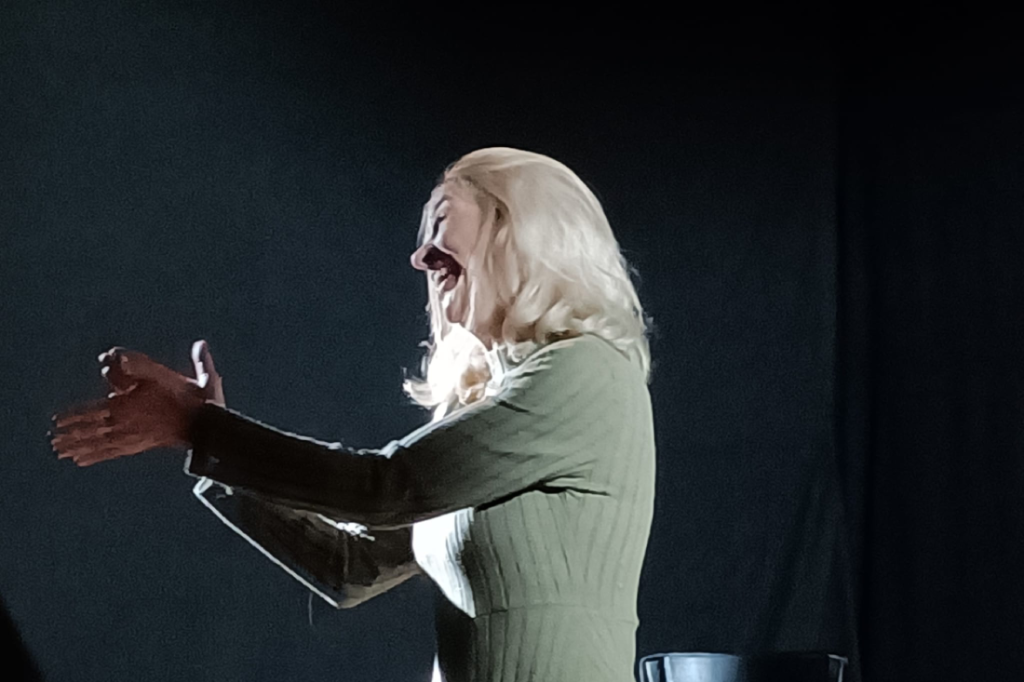Louise Brooks e il vaso di Pandora – Recensione Teatro
Nell’ambito della rassegna Portiamo il teatro a casa tua, ideata e creata da Mariagrazia Innecco, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo Louise Brooks e il vaso di Pandora, interpretato da Anna Giarrocco e Andrea Benfante. La produzione è a cura de “Il Teatrino di Bisanzio“.
Certe icone cinematografiche del passato hanno tutta la forza delle divinità del pantheon greco/romano, e, proprio come ci ricorda Hillman, da loro è vano fuggire, perché incarnano, anche e soprattutto, i nostri difetti, le nostre mancanze. Louise Brooks sembra fatta apposta per diventare il nostro oscuro oggetto del desiderio; con quel taglio alla garçonne, quel caschetto androgino che caratterizza le flappers evocate dalla spietata tenerezza di Fitzgerald, guarda l’abisso che le restituisce il suo sguardo. Felice l’idea di dedicarle una pièce, di ricordarla a ritroso, partendo dalla decadenza degli anni ’40, per costruire cinematograficamente, con una serie di flashback, la sua vicenda artistica e personale. Il palcoscenico diventa una macchina per il montaggio, sulla quale scorrono pellicole umane con nitrato d’argento. Avviene una sorta di miracolo, perché la cinematografia che si evoca, quella del profondissimo bianco e nero, nonché la stagione del cinema muto, sono omaggiate da una corrispondente recitazione.
Questa prende, efficacemente, esempio dagli stilemi del muto, delle slapstick, delle comiche, e, al momento giusto, sa bagnarsi delle lacrime di una strasberghiana immedesimazione. I fantasmi del passato fanno visita a questa diva, ma senza la confortante morale dickensiana. Piuttosto, qui sembrano psicodrammi moreniani rivissuti uno dietro l’altro, perché ella ritrovi pienamente se stessa. Il suo alter-ego, la sua bambola, quasi bidimensionale, creatura ribelle sfuggita dal mondo piatto della pellicola, viene continuamente svestita e vestita, obbediente (ma, silenziosamente, ribelle) all’imperativo pirandelliano del come tu mi vuoi. In scena è presente quasi come un totem e, insieme, un tabù, segno di un’altra, di un ineffabile inconscio che abita la protagonista. Schigolch – creatura da film espressionista, che avrebbe potuto abitare il salotto del dottor Mabuse -, il regista Pabst, il fumettista Crepax, che a lei si ispira per l’icona Valentina, ed altri personaggi ancora, si avvicendano e scorrono, veloci come fotogrammi nel proiettore.

Sono tracce mnestiche che vivono la loro porzione di un film che Louise, insieme, guarda e rivive, proprio come accade in una dimensione onirica. E, nel sogno, si infrangono i limiti dati di spazio e di tempo; in questa dimensione, anche le fotografie di altri divi, come Bogart o la Garbo, possono animarsi, e diventare un curioso e riuscito teatrino delle ombre, in questo caso di celluloide. In tutto questo viaggio al termine della notte, la protagonista, affiancata dalla poliedrica e fregolistica malleabilità al cambiamento scenico dell’altro interprete, ci fa, idealmente, salire su una giostra che gira veloce, che dà piacevoli vertigini. Si ha la sensazione, come nel film omonimo di Ophüls, che una novella Lola Montès racconti, su una pista circense, la sua storia, portando in dote la sintesi, unica e irripetibile di quell’ambiente: il grottesco e, insieme, il tragico.
Lei è il clown bianco, e il suo partner di scena l’augusto; l’elemento irrazionale, dionisiaco che, ogni volta, la fa saltare in una nuova realtà, insieme, esistenziale e cinematografica. Il corpo di Louise è trasumanato, così consumato dallo sguardo dalla platea da mostrare le lacerazioni da cui fa capolino la luce dell’anima, in grado di illuminare di poesia i suoi fonemi. Non c’è un’esitazione, un tempo morto, un solo atto gratuito o lasciato a se stesso, in questa rappresentazione. Tutto è necessario, tutto è là dove doveva essere, in quell’esatta sequenza dei 24 fotogrammi al secondo. Panta rei, tutto scorre; ma la fotografia di Louise diventa un ritratto di Dorian Gray in cui l’interno del vaso di Pandora, con tutti i suoi mali, si vede, a patto che ci si lasci andare in quella percezione da sindrome di Stendhal, da “ritratto ovale” di Poe. Un’ossessione, per gli altri e per se stessa.

Nel senso etimologico del termine di ob-sidere, di sedere di fronte, in modo da isolare l’oggetto del tormento, di assediarlo, di cannibalizzarlo idealmente come in un rito pagano, antico, apotropaico. Anna Giarrocco si immerge, letteralmente, nel personaggio con ogni centimetro della sua pelle e della sua carne; in uno stato come di trance ipnotica, posseduta dal daimon della recitazione, ci restituisce una Louise più viva ed autentica che mai. Mantiene, dall’inizio alla fine, una consapevolezza che si potrebbe definire intuiva, animale, con la diva. Lascia che sia il suo ventre a dialogare idealmente con lei, e il risultato è ottimo. Si muove prima coreuticamente, in una danza tribale, selvaggia, istintiva, per poi trovare una flessuosità nobile, stordente. Sembra guidata da una dea che la abita: una dea malata, perché non più adorata dai fedeli, ma pur sempre una divinità.
Andrea Benfante, essere istintivamente proteiforme, si muove con estrema agilità tra i cambi di personaggio, riuscendo a trovare sempre una forte caratterizzazione fisica, posturale e fonetica. Quasi sempre volutamente disturbante, diavolo tentatore o tentato, presenza che ora resiste, ora cortocircuita, di fronte al vaso di Pandora di Louise. Nel finale, dalla platea si intuisce che, malgrado l’attraversamento del travagliatissimo inferno grottesco, c’è ancora qualche stella ad aspettare all’uscita. Affiora, tra i rarefatti fonemi, che si assottigliano per arrivare all’essenziale, una verità silenziosa, un momento preziosissimo e luminoso, in cui la protagonista può vedersi nello specchio, finalmente ricomposto, come una, e non come nessuna o centomila. Ma bisogna far silenzio, o quell’intuizione svanirà subito. Finalmente avviene il miracolo della riconciliazione con quel vaso aperto di mali, oltre i quali, sul fondo, si può leggere la luce di una timida speranza di essere: essere al di là di ogni maschera.

Se questo articolo è stato di vostro interesse, vi invitiamo a leggere gli altri, che troverete nella sezione teatro, e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non scordate, inoltre, di ascoltare i nostri podcast per approfondire la conoscenza del vasto mondo teatrale.