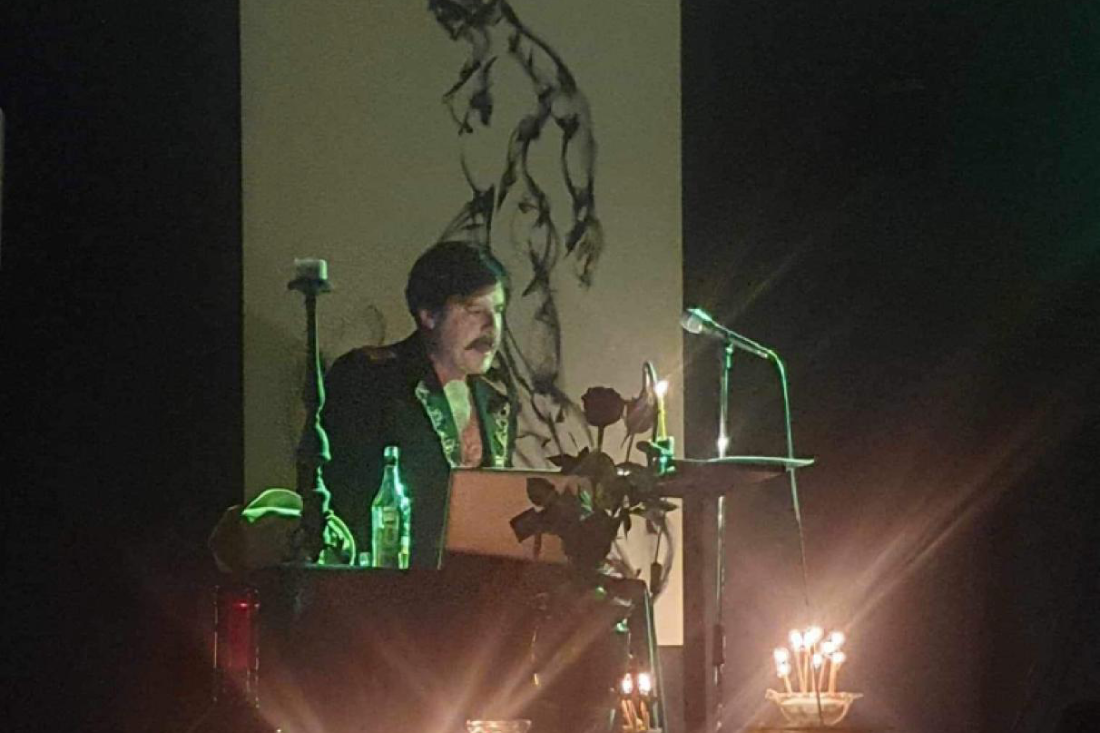Amiche – Recensione Teatro
Nell’ambito della rassegna Portiamo il teatro a casa tua, ideata e creata da Mariagrazia Innecco, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo Amiche, con Daniela La Pira e Chiara Malpezzi. Il testo e la regia sono a cura di Sergio Scorzillo.
Dove guarda l’attrice, mentre mastica pezzi di cuore, con il retrogusto di un’erba amara? Deve essere stato questo l’interrogativo del regista, mentre impostava le due donne, deliziosamente coinvolte in un passo a due verbale. Quell’altrove, quel punto al di là di ogni possibile platea, quell’invisibile centro di gravità che attira gli occhi felini, è il rito di passaggio, il superamento della carne, della barriera del dicibile; zona di struggente nostalgia che precede, o forse segue, la nascita di un personaggio, e, più generalmente, dell’essere umano. Sono terribilmente liquidi quegli occhi, e hanno i riflessi di certi ostinati raggi primaverili su specchi d’acqua che, sul tremulo orizzonte del ricordo, faticheresti a ricordare se hai davvero visto, o solo sognato. Ecco, dunque, l’intuizione improvvisa, l’acqua fredda in grado di risvegliarti i sensi: si tratta d’anima, in questa pièce. Si è, idealmente, in un interno tutto fatto di interiorità.
Il montaggio stesso, felicemente cinematografico, vale a testimoniare il tempo non più cronologico, ma cairologico; ricostruito dalla coscienza nell’argomento, nelle sovraimpressioni, nei salti in grado di plasmare, come un demiurgo, l’istante. Nella camera oscura psichica, si sviluppano queste eccezionali fotografie di esistenze declinate al femminile. Sono istantanee, nell’album di famiglia impresso sulle retine della platea, che bruciano letteralmente di sentimento, crepitando. Alcune battute, incastonate in preziosi monologhi, sono il dito bagnato che scorre sul bordo di una flȗte di cristallo; hanno l’odore dell’anima, inconfondibile, che ti sale su per le narici come un potente mentolo, in grado di stordire quel senso. La vicenda è ambientata nell’inquieta Dublino degli anni ’80; il Peter Falk del Cielo sopra Berlino direbbe: “Era a Dublino? Ma sì, non fa differenza, è capitato.” La vera geografia della storia è tutta costruita nell’anima. Vivono in scena la debole e la forte, il clown bianco e l’augusto.

E ancora, lo spirito apollineo e quello dionisiaco, Edith e Helen: ecco la sempiterna diade, all’imperitura, travagliata, ricerca della propria identità attraverso quella opposta. Seguendo Lacan, il desiderio è sempre il desiderio dell’altra; stavolta non è scritto sul tram, ma in certi sguardi reciproci, in certi sovrappensieri. In un mondo di uomini dalle mani troppo ingombranti e rudi, è meglio, per una donna, permettere che sia un’altra mano femminile a toccare il baco da seta della propria anima. In questa educazione sentimentale rimasta sospesa a metà, la timida e fragile Edith diventa uno specchio per la volitiva Helen, in un gioco delle parti che si fa osmotico, e in cui, con spirito bergmaniano, la persona è una continua dissolvenza incrociata tra un volto e l’altro. Se si vuole conoscere l’essere umano, questa è la lezione di psicoterapia ben adottata dal regista e autore Sergio Scorzillo.
Bisogna mettere uno specchio di fronte a un altro specchio: una donna di fronte a un’altra donna, una profondità di strati di fronte a un’altra profondità, un gioco di identificazioni che si perde, e si ritrova, nell’orizzonte della propria coscienza. I riferimenti al cinema non sono casuali, dal momento che il regista costruisce campi e controcampi; attimi d’ufficio, di vita, di intimità che sono la parte fondante nel montaggio esistenziale. D’altronde, era il buon Hitchcock ad affermare che il cinema è la vita, con tagli di pellicola nelle parti noiose. Ma c’è molto di più, qui. C’è la volontà, perfino superiore a quella di un febbricitante Fassbinder, di restituire il mélo in purezza, il cuore esposto nella sua verità, così com’è, con tutta la sua voglia di essere, le sue titubanze, i suoi pianti, i suoi sorrisi, i suoi pianissimo.

Gli stessi fanno da contrappunto ai momenti in cui il pedale di risonanza del piano è pigiato con decisione, e le dita tuonano sulla laringe con una forza invincibile. Tutta la maestria del regista e delle interpreti si gioca su questi dialoghi, in cui le parole sono solo una parte minimale dei significati. La parte maggioritaria è nascosta in quegli spazi interstiziali, in quelle incolmabili fenditure, quei sovrappensieri, quei gesti nervosi e improvvisi che spezzano il tempo, che ne sono la sincope. E ancora, in certi fonemi c’è tutto lo scavo archeologico dell’anima dei personaggi. Ascoltare certe battute obbliga a sorseggiarle, come potrebbe obbligarti a farlo un vino fortemente tannico, strutturato, che deve far conoscenza del gusto, che non può e non deve essere frettolosamente rovesciato nella gola. Un meritato plauso va certamente alle due interpreti, che hanno costruito una partita serratissima di parole, un concertato di gesti, di canti e controcanti.
Daniela la Pira è una Helen dal carattere forte come certi whiskey che sorseggia, con l’abilità di far sostare per un po’ le battute nel ventre, prima di tirarle a lucido sulla carta vetrata della laringe. Ma, quando mostra la sua fragilità , allora ti sembra di ascoltare il fruscio di certi tessuti di seta contro mobili antichi. Chiara Malpezzi è Edith: impiegata prossima, inizialmente, al rifiuto di vivere di un Bartleby melvilliano, scopre, come Ciàula, la sua Luna. I suoi fonemi si mostrano prima inamidati, rigidi, per poi sbocciare come fiori davanti alla platea. Anima fragile, tormentata da un super-io freudiano molto cattolico e parecchio materno, trova il suo es nell’amica, e ci racconta, con l’amica stessa, le molteplici stagioni dell’anima. Sergio Scorzillo ci mostra tutte le occasioni di luce, e tutta la nostalgia per la sua mancanza, dentro la tenera notte di Fitzgerald dei due personaggi.

Se questo articolo è stato di vostro interesse, vi invitiamo a leggere gli altri, che troverete nella sezione teatro, e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non scordate, inoltre, di ascoltare i nostri podcast per approfondire la conoscenza del vasto mondo teatrale.