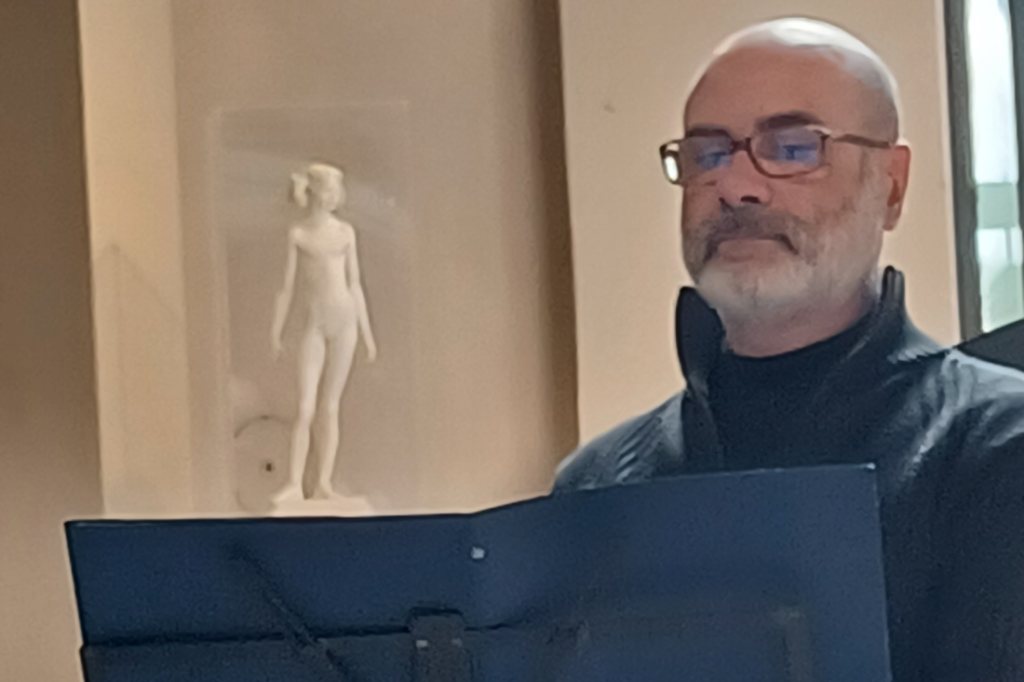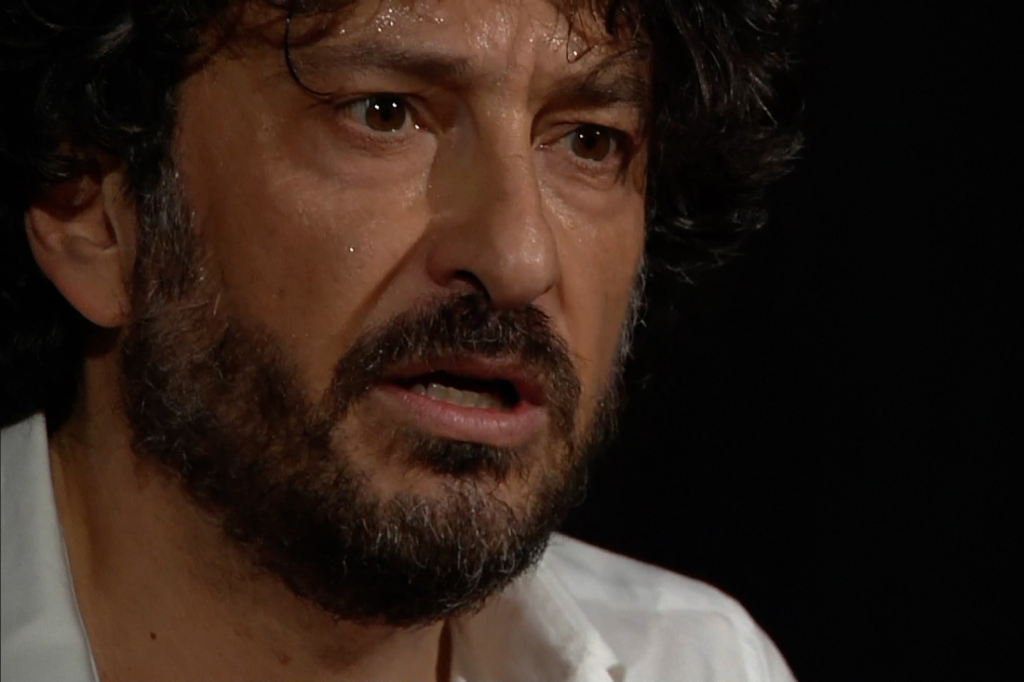AAA Cercasi sostegno per madre single e femminista con figlio maschio e adolescente – Recensione Teatro
Nell’ambito della rassegna digitale Portiamo il teatro a casa tua, ideata e creata da Mariagrazia Innecco, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo AAA Cercasi sostegno per madre single e femminista con figlio maschio e adolescente, scritto diretto e interpretato da Monica Faggiani.
Ci si interroga spesso su quale sia il segreto di un interprete; quale, per rubare un’espressione hegeliana, immediato indeterminato renda quel modo di recitare unico e irripetibile. Si cerca la soluzione, come di fronte a un teorema apparentemente irrisolvibile e indimostrabile, e poi la risposta appare improvvisamente, al pari di un lampo di luce. Questo è accaduto, osservando Monica Faggiani dalla platea a pochissima distanza, la stessa che permette ai fonemi dell’attrice di arrivare ancora pieni della sua presenza fisica, e di quel profumo metafisico dell’anima che è a portata di fiato. Monica, semplicemente, lascia che tutto sia, che tutto accada; si immerge nel testo scenico, come ci si potrebbe immergere nel mare. Partecipare alle sue rappresentazioni diventa una sorta di talassoterapia, lei lascia scorrere la drammaturgia su di sé, come Molly Bloom i suoi catartici sì nell’Ulisse di Joyce.
Ecco, la sua interpretazione è un sì a occhi chiusi, con un generoso sorriso pronto ad accoglierti. E’ un sì alla vita, non solo alla sua, ma a quella di ogni essere. Batte freneticamente sui tasti della macchina per scrivere della sua laringe, a una velocità che toglie il fiato; fa i gradini a due a due, a tre a tre, e ogni tanto, nel momento giusto, è come se si mettesse un dito sulle labbra, e ti invitasse a sostare per un istante, per accorgerti di ogni singolo respiro. L’occasione per parlare del suo essere madre, di suo figlio, usando il talking blues della stand up comedy, diventa, altresì, occasione per cogliere la natura, l’essenza del femminile, che, junghianamente, si sovrappone perfettamente con l’essenza dell’anima. E le parole sono il plic plic della pioggia, che si annuncia prima con un adagio musicale, poi si lascia andare a un allegro assai.

Esplode in un crescendo rossiniano che dà le vertigini. Corre Monica, corre anche laddove non corriamo noi, e corre a piedi scalzi, pur indossando elegantemente un paio di scarpe dal tacco vertiginoso. Mangia, divora il mondo che la circonda con i suoi sguardi, e ce lo restituisce con una recitazione trasparente come l’acqua. E son dannunzianamente fresche le sue parole, davvero come il fruscio che fan le foglie: ti divertono e ti inteneriscono, come l’affaccendarsi di uno scoiattolo intento a salire sull’albero. Il segreto del suo monologo è l’aver veicolato, nella maniera più diretta e immediata, cosa sia la maternità, rendendo la sua stessa interpretazione un ventre accogliente, trasformando il suo sorriso in un liquido amniotico, in cui sognare l’esistenza che verrà. Ha davanti a sé il microfono di un crooner, di una Ella Fitzgerald solamente un po’ più chiara.
Ha deciso, più che di cantarlo, di recitarlo, il suo blues, il suo jazz. E quando due labbra alla Tarantino si avvicinano a un microfono, si sa che niente sarà più come prima: è come si ritornasse a “in principio era il verbo”. Ci si accorge davvero, dalla parte del pubblico, quando il monologo va nella direzione giusta, e tutti i pezzi si incastrano uno dopo l’altro, come in questo caso. Ogni fonema diventa un mondo, un gioco frattalico dove si aprono altre immagini e, dentro di esse, altre ancora. E i suoni, certi suoni, ti trascinano nella loro danza vorticosa, chiedendo complicità e ottenendola. E il miracolo è lì, meno distante dell’invisibile freccia del respiro. Ci si accorge, con buona pace di Dürrenmatt, che la Pizia non è morta, ma è lì, pronta a oracolare le parole di invisibile divinità.

Lascia che a giocare nello spazio delle sue labbra sia Talia, la Musa della commedia. Allora può accadere un vero miracolo: che un sorriso, almeno per un lungo, lunghissimo, dostoevskijano istante, possa salvare il mondo, a patto che sia, come questo, completamente sincero, gratuito, spontaneo. Come le nuvole che, a un certo punto, l’acqua che trattengono la lasciano andare, naturalmente, ed ecco la pioggia. Monica cattura il suo pubblico perché decide di non incarnare l’arida concettualità dell’essere madre, ma, piuttosto, l’esercizio quotidiano della maternità, che ha più in comune con gli opposti di Eraclito, che con le idee platoniche. L’attrice racconta l’unica cosa che possa davvero raccontare, e con questo fa la differenza, un essere umano ad altri esseri umani: il proprio divenire, continuamente, il proprio scorrere nell’incessante fiume dell’esistenza. E la magia più grande è quella di far intravedere in questo mondo pieno di contraddizioni, di difetti e di storture, un po’ di Nirvana.
Basta cambiare le lenti, ascoltare una tua emozione o quella di chi ti circonda. Ecco che, allora, un po’ di poesia, persino un po’ di assoluto, si può trovare, ogni volta che un essere speciale si ricorda di te, vive al di là di te stessa e porta la tua traccia un po’ più in là del tempo che puoi attribuirti. Si impara tanto sulla maternità da questo spettacolo, molto di più e meglio di quanto si possa imparare da un qualsiasi manuale. L’utero non è un semplice organo biologico, ma, piuttosto, un categoria dello spirito, un’ulteriore cavità cardiaca, che può imparare, e insieme insegnare, ad amare. Tutto sommato, l’atto stesso della recitazione è profondamente materno: un atto accogliente, un abbraccio forte forte, uno di quelli in cui si vorrebbe essere davvero, completamente, fisicamente, un unico noi. A dimostrarlo, l’entusiasmo del pubblico al termine di questo appassionante monologo.

Se questo articolo è stato di vostro interesse, vi invitiamo a leggere gli altri che troverete nella sezione teatro e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non scordate inoltre di ascoltare i nostri podcast per approfondire la conoscenza del vasto mondo teatrale.