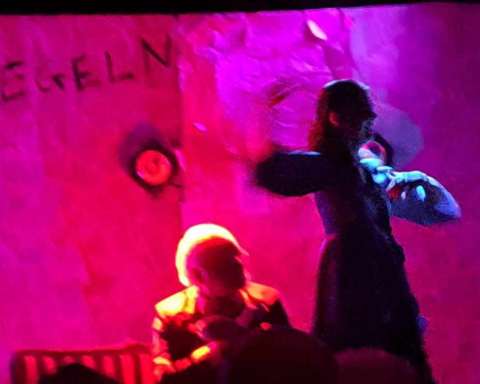Nell’ambito della stagione teatrale 2021/2022 di 4Parete vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo In questa lunga notte. L’autore e l’interprete di questo monologo, di questo flusso di coscienza più affilato della ghigliottina dell’antica Place de la Révolution, è l’attore Angelo Colombo. Si tratta di una sfida lanciata contro i fantasmi e e paure di ogni notte.
C’è una battaglia da sempre combattuta in teatro, per tutti i 25 secoli e oltre della sua storia, una lotta che finisce col diventare spina dorsale del teatro stesso: la battaglia tra la parola e il suo significato. E quella pietra che, a volte, si fa fatica a rigurgitare, che nasce nella gola, nella laringe, e ancor prima nell’anima, in forma di confusa morula, fa sentire il suo tonfo fatale sulle tavole del palcoscenico. E, da lì, il tormento eterno del significante che cerca di guardare il suo significato, come un uomo potrebbe tentare di osservare la propria schiena. L’attore Angelo Colombo tutto questo lo sa, contrariamente ad Alice della canzone di De Gregori, e le impasta ben bene le parole, ci immerge le mani, e insieme tutti i sensi; le lascia gocciolare, le suda letteralmente dalle labbra. Hanno consistenza.
Possiedono una propria liquidità, fisicità, sono corpi testoriani che si cercano, nella carne, il proprio dio mancato. L’interprete prende una sorta di rincorsa, e tira su, in un fiato, più vento di quanto ne possa contenere l’otre di Eolo. E poi lo restituisce, colmo del polline fecondante delle sue parole; fa, e fa sentire, tutta la fatica di una corda metafisica su cui rincorre disperatamente il proprio senso. Qui non c’è un Camus che abbia pietà di Sisifo, ma c’è un macigno che spacca i muscoli, apre ferite laceranti dalle quali esce tutto il profumo di una struggente poesia, di fiori di un male subìto, di pugni nelle tasche del paltò di Rimbaud, che sono sempre più sfondate. Com’è vero, com’è giusto, come tremendamente necessario questo viaggio al termine di una notte, al tempo stesso esteriore e dell’anima. Nessun cielo stellato, di kantiana memoria, per trovare una morale, una via esistenziale.

C’è la nostalgia di quelle luci, c’è la volontà di rendere quell’eco luminosa in forma di parola. Da qualche parte si annida l’insonnia di Cioran, gravida della verità più scomoda: delle filosofie che rischiano di avere la tentazione di tagliarsi la gola con il rasoio di Ockham, o di vivere l’essere per la morte di heideggeriana memoria, come l’attesa del condannato, che sente già il freddo della lama incombergli sul collo. La magia di questo monologo è proprio lì, nella presa di coscienza tragica della propria mortalità, della propria finitudine, in quell’urlo di Munch che si ripete serialmente come le Marilyn di Warhol. Allora non si sta più dalla parte del si impersonale, della burattinizzazione del quotidiano, della routine di un tempo apparentemente circolare, che cerca di barare con se stesso. Improvvisamente, la prospettiva di una fine riporta il centro di gravità sul proprio sé.
E la notte non può che avere il sapore di quella dell’Innominato, piena di dubbi e tormenti. L’attore sembra un Lucky uscito dritto dritto dall’Aspettando Godot di Beckett; un Lucky che può, però, esperire i suoi piccoli grandi sogni dostoevskijani, da uomo ridicolo. A tratti, con quel suo particolare cappello, col suo girare su stesso con la meccanica musicalità della ballerina di un carillon, ha tutta la parvenza di un particolarissimo derviscio rotante, di un mistico metropolitano che cerca il suo dio nell’estasi della parola e del gesto, nell’irrazionalità conscia, nel corto circuito deliberato. Il suo è un flusso di coscienza continuo, ininterrotto, che fa ridere e piangere allo stesso tempo. La sua drammaturgia ha una necessità primaria, igienica, di pulizia dell’anima, per smaltirne le tossine, per grattare via un po’ di quel black con cui i suoi personalissimi Rolling Stones ne hanno tinteggiato le pareti.

Angelo Colombo è la rivincita del guitto evocato dal Macbeth shakespeariano: ha tanta di quella poesia in gola che rischia di soffocarlo, di trasformarsi in una tosse metafisica, in una malattia che nemmeno il più bravo Molière potrebbe fingere di avere. Ci vuole del coraggio per mostrare i propri ko esistenziali, per lasciarsi guardare l’anima così com’è, nella sua nudità, in quelle imperfezioni che ce la fanno sentire ancora più nostra, di tutti noi. Cerca disperatamente, selvaggiamente, un amore che renda il suo presente davvero tale. Raramente capita di vedere, di ascoltare una dichiarazione d’amore così autentica nei confronti del proprio pubblico. Questa è una Messa umana, del tutto umana: una cerimonia profondamente religiosa e insieme umanista, il grido, la sirena d’allarme che ci invita ad essere svegli davvero, e per sempre. Ecco, allora, che la poesia appare, dopo che le mani si sono escoriate a furia di scavare.
Quando i polmoni arrancano, per le masse d’aria che hanno dovuto gestire, e le parole hanno vissuto tutta la loro vita, anche quella che non avrebbero potuto avere, affiora il tesoro inestimabile della poiesis; è una poesia ancora più preziosa perché sa di carne e di sudore, perché l’uomo l’ha scritta sul foglio della sua stessa esistenza. Vorace, dionisiaco, ebbro, con la voglia di abbracciare il pubblico lanciata in ogni singolo fonema, questo attore ti mette le mani nella pancia come un chirurgo del ventre, e ti lascia dentro la rosa con tutte le sue spine, perché l’autentica bellezza fa male, anche, e ti muove qualcosa dentro. E, quando questo accade, niente sarà più come prima. Per la platea questo viaggio è necessario, splendido. Il pubblico riesce a riveder le stelle, un attimo prima che si liberi un catartico, lungo, dionisiaco applauso di gratitudine nei confronti dell’interprete.

Se vi è piaciuto questo articolo, vi consigliamo la lettura degli altri che troverete nella sezione teatro e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non dimenticate inoltre di ascoltare il nostro podcast per approfondire i vari aspetti del mondo teatrale.