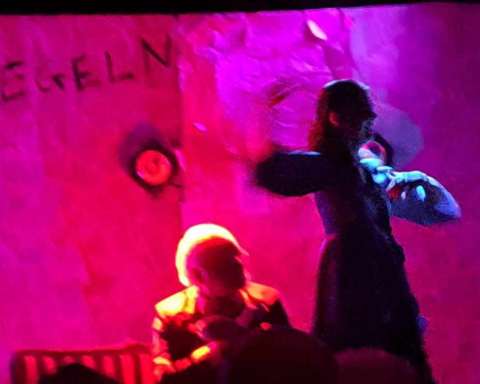Nell’ambito della rassegna digitale Portiamo il teatro a casa tua, ideata e creata da Mariagrazia Innecco, vi presentiamo la nostra recensione dello spettacolo Son la Pia, un monologo recitato da Sandra Tognarini, e diretto da Moniga Faggiani. Il lavoro teatrale trae la propria ispirazione dal personaggio citato da Dante nel canto V del Purgatorio.
Quanto va veloce questa Pia, sembra far venire il fiato corto persino al vento. E corrono le sue parole, e sono tante, precise, puntute, come frecce della battaglia di Azincourt. Scaglia la sua pietra fonetica dalla catapulta del suo corpo per abbattere le mura dell’indifferenza, del già detto. Mostra i pugni prometeici, mostra i denti, combatte fino all’ultimo fonema, e anche oltre. A piedi nudi sul palcoscenico, non sta sulle punte metafisiche di un’impalpabile étoile, ma con tutto il palmo sulla terra; la sua è una teologia immanente, combattiva, dialettica, ha voglia di tragedia, e non ha bisogno di alti coturni per portarla in scena. Il suo nero si lascia vivere da lampi di luce caravaggesca; è una cura omeopatica spirituale, un paint it black che, da Mick Jagger, approda ad un castello della Maremma. A buona ragione Svevo, citando la sua scrittura, ragionava di necessità igienica.
E il concetto è ancora più evidente in questa pièce, dove una donna pulisce, nella neve della poesia, un cuore ferito dalla vita. Dietro alla storia di Pia c’è anche la sua, ma anche quella di ogni spettatore; siamo tutti lì, imprigionati in un bel castello un bel po’ diverso, e molto meno bello di quello infantile del marcondirondirondello. Come questo personaggio, abbiamo le tasche piene di sassi da scagliare contro un cielo, per farlo sanguinare di divinità, per lottare ancora una volta la battaglia impari, se non impossibile, contro il destino. Ha poca voglia questa Pia, e la si può capire, di lasciarsi imprigionare nelle incisioni di Doré, nel purgatorio dantesco, turrito quanto la sua medievale magione. Conserva un verso, il più importante, forte quanto l’evidenza cartesiana: “Son la Pia”. E fa di tutto per essere presente a se stessa e agli altri, sta tutta da una parte del monologo amletico.

E veste ancora della sua pelle il teschio di Yorick. Più scava nella sua anima, a mani nude, fino a farsi sanguinare le dita, più ritrova la sua biografia, se stessa, sulla superficie lucida di uno specchio, lo stesso nel quale si trucca all’inizio dello spettacolo. Ha le sue voci di dentro, che per il pubblico diventano voci provenienti da un altrove, voci di fuori che sono la condensa, la rugiada del loto, il faticoso sudore di una sacerdotessa della scena, che pronuncia il suo mantra esistenziale con la forza di chi, idealmente, sembra dire al pubblico: “Non me ne andrò di qui finché io non sarò salva, e voi insieme a me”. La sua guasconeria sferzante, la sua vis recitativa, hanno tutta lo spirito di un Romeo che giura a Tebaldo che accadrà qualcosa di definitivo, di mortale, a lui, all’altro o a entrambi.
Perché il teatro deve essere così, una sfida consumata sulla corda sottilissima, ma anche di acciaio, la stessa giocata dal funambolo Philippe Petit tra le Torri Gemelle. Ecco, Sandra Tognarini, autrice ed interprete di questo efficace monologo, cammina, per un’ora, a più di 400 metri d’altezza dalle banalità, dalle convinzioni precofenzionate, dalle convenzioni, dal chiacchiericcio del si dice, del si pensa, quello delle deandriane regine del tua culpa. Ha camminato dietro il cielo Sandra, ha rischiato la ghirba, e ha vinto la sfida. Ha coraggio da vendere, e una voglia tremenda, feroce, strabordante, di accendere con la torcia della sua passione teatrale la platea. Ha l’urgenza di dire; di più, di trovare quello spazio tra la parola e il pensiero, tra la volontà e l’azione, quell’incolmabile fenditura che solo un’anima poetica può colmare. La sua canzone arrabbiata è terribilmente struggente, ma sa farsi carezza, dolce, come la luce della luna piena.

Quando ci racconta del padre, diventa cristica e insieme mariana, costruisce la sua personalissima preghiera, quella che potrebbe pregare anche l’essere più lontano da qualunque forma di spiritualità. Si muove in tondo, ma già, con le parole, si scaglia, con un’irresistibile forza centrifuga, al di là di quello spazio chiuso che eternamente ritorna su stesso. Uccide l’uroboro nella culla, come un Ercole, e ritrova la possibilità di un sì, di un no, di una direzione. La regia di Monica Faggiani è quella di una levatrice attenta, pronta a far tutto per far partorire il testo scenico. Permette a questa sonata esistenziale di essere piena, completa, e le dita martellano beethovenianamente sui tasti, per dire, nell’unico modo possibile, tutta l’anima che c’è. Ma quando, per un attimo, Pia sosta sulla scena, oppone la verticalità cosciente all’incedere delle cose, trova i vertici del suo modo unico di coniugare la tragicità.
Sta lì, si lascia guardare e si guarda, e alla fine abbandona anche quella consapevolezza, raggiungendo il mistero di un’intuizione di mille esistenze in un solo istante. È un istante, certo, chiuso tra innumerevoli battaglie, ma vale quanto un’eternità. Quanta energia in un singolo corpo può vivere ed esplodere, tutta insieme, quando è aperto il vaso; e, per una volta, è il caso di ringraziare Pandora per averlo sturato. Pia non è soltanto Pia: è la vita, che ha fame di se stessa e di verità, la vita che vuole riscattarsi, che vuole raccontarsi per capirsi meglio. Questo messaggio teatrale è urgente: ci scuote con le sue battute, ci anima, in un senso letterale della parola, ci fa anima, e ci commuove. La tragedia ha avuto una bella iniezione adrenalinica con questo spettacolo, e si è risvegliata, con la repentinità di Mia Wallace, dall’overdose delle tante, troppe laringi bronzate.

Se questo articolo è stato di vostro interesse, vi invitiamo a leggere gli altri che troverete nella sezione teatro e le altre recensioni presenti sul nostro sito. Non scordate inoltre di ascoltare i nostri podcast per approfondire la conoscenza del vasto mondo teatrale.